Storia di Mantova comprensivo di Audio da ascoltare
Mantova: Una Storia in Tre Atti – Di Dei, Duchi e Geni
(Suono di acqua che lambisce dolcemente, una campana di chiesa in lontananza)
C’è un’immagine di Mantova che rimane impressa nella mente: quella di una città che sembra galleggiare, un’isola di pietra e mattoni abbracciata su tre lati dalle acque placide dei laghi artificiali, creati nel XII secolo imbrigliando il corso del fiume Mincio. Questa non è semplice geografia; è destino. Questo abbraccio acquatico ha protetto e al contempo isolato Mantova, forgiandone la storia, il carattere e l’anima. Come ha fatto questa città, che la leggenda vuole nata dalle lacrime di una profetessa, a trasformarsi in una sfolgorante capitale del Rinascimento, una “piccola Atene” , per poi subire una caduta catastrofica e rinascere come simbolo della lotta nazionale?
La sua storia si dipana come un’opera teatrale in tre grandi atti. Il primo atto narra delle fondamenta, gettate da divinità mitiche, consolidate dai Romani e contese dai Comuni medievali. Il secondo è l’epopea lunga quattro secoli della dinastia Gonzaga, un’incredibile saga di potere, ambizione e mecenatismo che ha trasformato la città in un tesoro d’arte. Il terzo e ultimo atto racconta la trasformazione di Mantova in fortezza, il suo ruolo cruciale nel Risorgimento e la sua eredità duratura come patrimonio dell’umanità.
Parte I: Le Fondamenta del Potere (Origini – 1328)
La Lacrima della Veggente e la Culla del Poeta
La storia di Mantova inizia nel mito, un racconto intriso di magia e profezia. Le fonti classiche, in particolare il poeta Stazio, narrano di Manto, la veggente figlia dell’indovino tebano Tiresia. Dopo la caduta di Tebe, Manto vagò a lungo per l’Italia, fermandosi infine sulle rive del Mincio. Qui, le sue lacrime di dolore crearono i laghi che ancora oggi circondano la città, acque che si diceva conferissero doni profetici a chi le beveva.
A questa versione si affianca quella del più illustre figlio di Mantova, Virgilio. Nella sua Eneide, il poeta lega le origini della città al mondo etrusco, narrando di Ocno, figlio di Manto e del “fiume etrusco”, che fondò una città dandole il nome della madre: Mantua. Questa narrazione stabiliva per Mantova un’origine nobile e semi-divina.
Secoli dopo, un altro gigante della letteratura italiana, Dante Alighieri, si sentì in dovere di intervenire su questo mito fondativo. Nel Canto XX dell’Inferno, Dante fa pronunciare a Virgilio stesso una versione “razionalizzata” della storia: Manto, descritta come una “vergine cruda”, sarebbe morta in questo luogo desolato e, solo in seguito, degli uomini avrebbero fondato la città sulle sue ossa, “sanz’altra sorte”, ovvero senza alcun sortilegio, scegliendo il nome in suo onore. Questo scontro tra miti non è una semplice curiosità letteraria, ma rappresenta una lotta per l’identità stessa della città. L’intervento di Dante è un tentativo, tipico dell’incipiente Umanesimo, di riportare la storia sotto il controllo dell’agire umano, sottraendola al fato e alla magia. Tuttavia, la contraddizione interna all’opera di Dante stesso, che nel Canto XXII del Purgatorio colloca Manto tra i pagani virtuosi del Limbo, dimostra quanto fosse difficile sradicare del tutto la potente tradizione mitica.
Al di là della leggenda, l’archeologia conferma un’origine ben più antica. I primi insediamenti furono degli Umbri, seguiti dagli Etruschi nel VI secolo a.C., che compresero il valore strategico dell’area per i traffici commerciali lungo il Po e il Mincio. I Romani conquistarono la città intorno al 214 a.C. , la fortificarono e le diedero un impianto urbanistico ortogonale le cui tracce sopravvivono ancora oggi nell’allineamento di Via Cairoli e Piazza Sordello. Resti di quell’epoca sono visibili nei mosaici di una domus romana in Piazza Sordello e nelle pavimentazioni stradali rinvenute sotto i portici di Via Broletto. L’evento più significativo dell’epoca romana fu, nel 70 a.C., la nascita nei pressi di Mantova di Publio Virgilio Marone, il poeta che avrebbe legato per sempre la sua città natale al cuore epico di Roma. Con i Romani arrivò anche il Cristianesimo, legato a una reliquia che segnerà profondamente la storia spirituale della città: il “Preziosissimo Sangue di Cristo”, che la tradizione vuole portato a Mantova dal centurione Longino. Il suo ritrovamento nell’anno 804 portò alla creazione della diocesi, consacrando Mantova come importante centro di pellegrinaggio.
L’Età del Comune
Dopo la caduta dell’Impero Romano, Mantova visse secoli turbolenti, segnati dalle invasioni dei Goti, dei Longobardi e infine dal dominio dei Franchi. Intorno all’anno Mille, la città entrò nei domini della potente famiglia dei Canossa. Divenne un possedimento chiave, tanto da essere elevata a capitale da Bonifacio III di Canossa e da vedere la nascita, nel 1046, di sua figlia, la celebre Contessa Matilde. L’importanza di Mantova in questo periodo è testimoniata dal Concilio che vi si tenne nel 1064, un evento cruciale nel contesto della Lotta per le investiture.
Alla morte di Matilde nel 1115, Mantova, come molte altre città del nord Italia, colse l’opportunità per affermare la propria autonomia, costituendosi in “Libero Comune”. Questa indipendenza fu formalmente riconosciuta con il Trattato di Costanza del 1183, che garantì ai comuni della Lega Lombarda ampi margini di autogoverno.
Il XIII secolo fu caratterizzato da aspre lotte di potere tra le famiglie nobiliari locali. Da questi conflitti emerse la figura del ghibellino Pinamonte dei Bonacolsi, che nel 1272 assunse la carica di Capitano del Popolo, instaurando di fatto la prima signoria sulla città. Sotto i Bonacolsi, il centro urbano di Mantova iniziò a prendere la sua forma monumentale, con la costruzione del Palazzo del Podestà, del Palazzo della Ragione e del primo nucleo di edifici che sarebbero poi diventati il Palazzo Ducale. I Bonacolsi governarono per oltre cinquant’anni, ma il loro potere, sempre più assoluto, finì per generare malcontento e preparare il terreno per l’ascesa di una famiglia rivale, che attendeva nell’ombra il momento propizio per colpire.
Parte II: Il Secolo dei Gonzaga (1328 – 1708)
L’Ascesa dei Gonzaga
La notte del 16 agosto 1328 segnò una svolta epocale per Mantova. Con un colpo di stato tanto audace quanto spregiudicato, Luigi Gonzaga, un tempo alleato dei signori in carica, rovesciò il dominio di Rinaldo “Passerino” Bonacolsi. Non si trattò di una semplice presa di potere con la forza, ma di un’operazione politicamente sofisticata. I Gonzaga sfruttarono il pretesto della scomunica per eresia che gravava su Rinaldo e si assicurarono l’appoggio militare di un potente vicino, Cangrande I della Scala, signore di Verona. Come macabro trofeo e monito perenne, il corpo mummificato di Passerino Bonacolsi venne conservato per secoli all’interno del Palazzo Ducale.
La famiglia Gonzaga, originaria del vicino borgo omonimo e il cui cognome originale era Corradi, aveva pazientemente costruito la propria ascesa per oltre un secolo, accumulando terre, ricchezze e cariche pubbliche. Dopo il colpo di stato, Luigi Gonzaga fu eletto Capitano del Popolo e poi nominato Vicario Imperiale, assicurandosi così sia la legittimazione popolare sia quella imperiale. Il successo dei Gonzaga si fondava su una combinazione di strategie vincenti: le ingenti rendite derivanti dalle loro proprietà terriere, i profitti ottenuti come abili condottieri al servizio delle maggiori potenze italiane, i lucrosi rapporti commerciali con la Repubblica di Venezia e una oculata politica di alleanze matrimoniali con le principali dinastie dell’epoca.
Navigando con abilità nel complesso scacchiere politico del Nord Italia, i Gonzaga riuscirono a destreggiarsi tra le ambizioni di Milano, Venezia e Ferrara. Il loro prestigio e la loro ricchezza crebbero costantemente, fino a raggiungere un traguardo fondamentale nel 1433: in cambio di 120.000 fiorini d’oro, Gianfrancesco Gonzaga acquistò dall’Imperatore Sigismondo il titolo di Marchese. Fu un passo cruciale, che rendeva il loro dominio ereditario e li inseriva a pieno titolo nell’aristocrazia europea.
Il Rinascimento Trasformato
Il vero artefice dell’età dell’oro di Mantova fu Ludovico II Gonzaga, detto “il Turco”. Il suo matrimonio con la principessa tedesca Barbara di Brandeburgo ne consolidò il prestigio internazionale. Nel 1459, Ludovico ospitò il Concilio di Mantova, indetto da Papa Pio II per organizzare una crociata contro i Turchi, portando in città il papato e la sua corte di intellettuali. Questo evento attrasse una figura destinata a cambiare il volto della città: Leon Battista Alberti. Genio universale del Rinascimento, Alberti portò a Mantova la sua rivoluzionaria visione architettonica, progettando la Basilica di Sant’Andrea e la chiesa di San Sebastiano, opere che contribuirono a creare il “volto rinascimentale” di Mantova. L’anno seguente, nel 1460, Ludovico fece l’ingaggio più importante della sua vita: nominò Andrea Mantegna pittore di corte. Mantegna trascorrerà il resto della sua esistenza a Mantova, lasciando un’impronta indelebile sulla città e sulla storia dell’arte.
Nel 1490, la corte mantovana accolse un’altra figura straordinaria: Isabella d’Este, giunta a soli sedici anni come sposa di Francesco II Gonzaga. Proveniente dalla raffinatissima corte di Ferrara, Isabella portava con sé un’intelligenza formidabile e un gusto impeccabile. Non fu solo una marchesa, ma una vera protagonista della politica europea. Governò Mantova con abilità e diplomazia durante le frequenti assenze del marito, prigioniero dei Veneziani. Ma la sua fama è legata soprattutto al suo ruolo di mecenate, una delle più importanti ed esigenti della storia. La sua vastissima corrispondenza, di cui si conservano circa 30.000 lettere, documenta la sua instancabile ricerca di artisti del calibro di Leonardo da Vinci, dal quale ottenne un celebre disegno ma mai il ritratto dipinto che tanto desiderava, e Tiziano. Il suo studiolo e la sua grotta nel Palazzo Ducale erano spazi leggendari, collezioni d’arte e di antichità che erano la manifestazione fisica del suo status e del suo intelletto. Il suo salotto attirava le menti più brillanti dell’epoca, come Baldassarre Castiglione e Ludovico Ariosto. Fu anche patrona della musica, rendendo la corte di Mantova un centro di riferimento per compositori come Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara.
La tradizione di grande mecenatismo fu continuata da suo figlio, Federico II Gonzaga. La sua politica filo-imperiale gli valse, nel 1530, il titolo di Duca da parte dell’Imperatore Carlo V, elevando Mantova al rango di Ducato. Nel 1524, un evento segnò un’altra svolta artistica per la città: l’arrivo di Giulio Romano, il più talentuoso allievo di Raffaello. Federico gli commissionò la costruzione di un palazzo per gli ozi e i piaceri su un’isola ai margini della città, dove sorgevano le scuderie di famiglia. Quel progetto divenne Palazzo Te, il capolavoro di Giulio Romano e una delle creazioni più straordinarie del Manierismo, concepito non come dimora per uomini, ma, come scrisse il Vasari, come una “casa degli Dei”.
I Teatri del Potere: Palazzo Ducale e Palazzo Te
L’arte nella Mantova dei Gonzaga non era mai puramente decorativa; era un sofisticato strumento di governo, un “teatro del potere”. In un’epoca in cui Mantova era un “piccolo Stato” circondato da vicini potenti, i Gonzaga, privi di una forza militare schiacciante, usarono la cultura come arma e come scudo. Attraverso il mecenatismo, costruirono e proiettarono un’immagine precisa di sé: sovrani legittimi e favoriti dal cielo, colti intenditori e potenti alleati dell’Impero. I loro palazzi divennero palcoscenici dove l’arte e l’architettura erano la scenografia per impressionare gli alleati, intimidire i rivali e consolidare il proprio mito.
Il Palazzo Ducale ne è la prova più imponente. Non un singolo edificio, ma una vera e propria città nella città, un complesso labirintico di oltre 500 stanze, cortili e giardini, cresciuto in quattro secoli di dominio. È un registro architettonico della dinastia, che si snoda dalla Corte Vecchia al Castello di San Giorgio, fino alla Corte Nuova progettata da Giulio Romano. Al suo interno, nel Castello di San Giorgio, si trova il capolavoro assoluto di Andrea Mantegna: la Camera degli Sposi, o Camera Picta, affrescata tra il 1465 e il 1474. Entrarvi significa immergersi in una celebrazione della dinastia Gonzaga. Non è un semplice ritratto di famiglia, ma una potente dichiarazione dinastica. Sulle pareti vediamo Ludovico II, la moglie Barbara di Brandeburgo, i figli, la corte, persino il cane di famiglia, Rubino. L’affresco li ritrae come una potenza stabile e multigenerazionale, che riceve emissari e intrattiene rapporti con i più alti vertici del potere. La sua funzione era quella di legittimare il dominio gonzaghesco, rappresentandolo come ordinato e quasi divinamente sancito. L’opera è rivoluzionaria per il suo oculo in trompe-l’œil sul soffitto, il primo scorcio dal basso verso l’alto nella storia dell’arte, che crea una straordinaria illusione di uno spazio aperto verso il cielo. La stanza nasconde anche dei segreti, come l’autoritratto di Mantegna celato nel fogliame di un pilastro e la commovente inclusione della nana di corte, a testimonianza del suo ruolo nella vita della famiglia.
Se il Palazzo Ducale era il centro del potere ufficiale, Palazzo Te era la villa suburbana dedicata all’otium, al piacere e ai ricevimenti spettacolari, come quelli in onore dell’Imperatore Carlo V. Ogni sala è un’esperienza immersiva. La Sala dei Cavalli celebra i magnifici destrieri di razza dei Gonzaga, ritratti a grandezza naturale, simbolo di orgoglio aristocratico e ricchezza. La Sala di Amore e Psiche è un’esplosione di sensualità e gioia pagana, un’audace celebrazione dell’amore illecito tra Federico II e la sua amante, Isabella Boschetti, che dimostra la sicurezza di un sovrano che non teme di esibire la propria vita privata. Ma il culmine del palazzo è la Sala dei Giganti. Qui, il visitatore viene proiettato al centro della mitologica battaglia tra gli dei dell’Olimpo e i Giganti. L’affresco ricopre interamente le pareti e il soffitto, dando l’impressione che l’architettura stessa stia crollando. È una dimostrazione terrificante e sbalorditiva di virtuosismo artistico, ma anche una potente allegoria politica. Ospitando qui l’Imperatore Carlo V, Federico II inviava un messaggio inequivocabile: così come Giove schiaccia i Giganti ribelli, l’Imperatore annienterà i suoi nemici, e io, Duca di Mantova, sono dalla parte di Giove.
| Opera/Progetto | Committente/i | Artista/Architetto Principale | Date | Significato |
| Basilica di Sant’Andrea | Ludovico II Gonzaga | Leon Battista Alberti | Iniziata nel 1472 | Capolavoro dell’architettura rinascimentale, modello per innumerevoli chiese successive. |
| Camera degli Sposi (Camera Picta) | Ludovico II Gonzaga | Andrea Mantegna | 1465-1474 | Apice della pittura illusionistica, manifesto politico e celebrazione dinastica. |
| Palazzo Te | Federico II Gonzaga | Giulio Romano | 1524-1534 | Vertice dell’architettura e della pittura manierista, villa per gli ozi e teatro del potere. |
| Corte Nuova (Palazzo Ducale) | Federico II Gonzaga | Giulio Romano | Dal 1536 ca. | Ampliamento del complesso ducale in stile manierista, con appartamenti e gallerie. |
| Studiolo e Grotta | Isabella d’Este | Vari artisti (es. Mantegna, Perugino) | Fine XV – Inizio XVI sec. | Spazi privati di collezionismo e cultura, espressione del gusto e dell’intelletto della marchesa. |
La Grande Catastrofe
Dopo i fasti del XVI secolo, la qualità della leadership gonzaghesca iniziò a declinare. Gli ultimi duchi non possedevano l’acume politico dei loro antenati. Vincenzo II, l’ultimo della linea diretta, è ricordato soprattutto per aver venduto parte della magnifica collezione d’arte di famiglia per far fronte ai debiti.
Nel 1627, con la sua morte, la linea diretta dei Gonzaga si estinse. L’erede designato era Carlo Gonzaga-Nevers, appartenente a un ramo francese della famiglia. Questa successione era inaccettabile per le potenze asburgiche, Spagna e Sacro Romano Impero, che non potevano tollerare un duca filo-francese a capo dei territori strategici di Mantova e del Monferrato. La disputa sfociò nella devastante Guerra di Successione di Mantova (1628-1631).
Il conflitto culminò in uno degli eventi più tragici della storia italiana. Un esercito imperiale di 36.000 mercenari lanzichenecchi assediò la città. Indebolita dalla peste, Mantova cadde nel luglio del 1630. Seguì un saccheggio orribile e sistematico che durò giorni. La devastazione fu totale: il palazzo ducale fu spogliato di ogni tesoro rimasto, le chiese profanate, la popolazione massacrata o cacciata, il ghetto ebraico depredato. La città che era stata un gioiello del Rinascimento fu ridotta a uno “stato miserabile”, con lo spirito spezzato, la ricchezza svanita e la popolazione decimata.
Sebbene il Trattato di Cherasco (1631) avesse reinsediato i Gonzaga-Nevers in una città in rovina, la dinastia era ormai un’ombra di sé stessa. L’atto finale si consumò con l’ultimo duca, l’inetto Ferdinando Carlo. Avendo parteggiato per i francesi durante la Guerra di Successione Spagnola, fu dichiarato fellone dagli austriaci vincitori e costretto all’esilio. Nel 1707-1708, dopo quasi quattrocento anni, il dominio dei Gonzaga ebbe fine. Mantova fu annessa ai domini degli Asburgo d’Austria.
Parte III: Gli Echi della Storia (1708 – Oggi)
La Fortezza del Risorgimento
Sotto il dominio austriaco, l’identità di Mantova cambiò radicalmente. Da capitale culturale, divenne una fortezza militare di primaria importanza strategica. Entrò a far parte del “Quadrilatero”, il sistema difensivo che garantiva agli Asburgo il controllo del Nord Italia, trasformandosi in un’enorme caserma che ospitava fino a 10.000 soldati. Dopo una breve parentesi napoleonica, durante la quale le sue fortificazioni furono ulteriormente potenziate, Mantova tornò sotto il controllo austriaco nel 1815.
Fu in questo periodo che la città divenne uno dei centri nevralgici del Risorgimento italiano. Il Castello di San Giorgio, un tempo scrigno della Camera degli Sposi, fu trasformato in un famigerato carcere politico austriaco. L’oppressione asburgica alimentò i moti liberali e nazionalisti, che culminarono nella tragica ed eroica vicenda dei Martiri di Belfiore (1851-1855). Un comitato rivoluzionario mazziniano clandestino, guidato dal sacerdote Don Enrico Tazzoli, fu scoperto dalle autorità austriache. Il registro cifrato di Tazzoli, basato sul testo del Pater Noster, fu decifrato, portando a un’ondata di arresti. Undici patrioti, tra cui lo stesso Tazzoli, il medico Carlo Poma e l’eroe delle Dieci Giornate di Brescia, Tito Speri, furono impiccati nella Valletta di Belfiore, appena fuori le mura della città. Il loro sacrificio ebbe un’eco enorme in tutta Italia, trasformando Mantova in un simbolo della lotta per l’unità nazionale.
Finalmente, nel 1866, in seguito alla Terza Guerra d’Indipendenza, Mantova fu annessa al neonato Regno d’Italia, chiudendo il lungo capitolo della dominazione straniera.
L’Eredità Vivente
Mantova oggi non è una città congelata nel passato. Il 7 luglio 2008, insieme alla vicina Sabbioneta, la “città ideale” creata da un altro ramo dei Gonzaga, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La motivazione riconosce il valore eccezionale del sito: Mantova rappresenta l’ideale rinascimentale applicato alla trasformazione di una città esistente, mentre Sabbioneta incarna la creazione di una città nuova da zero. Insieme, testimoniano in modo unico l’ambizione e la visione urbanistica del Rinascimento.
La vita culturale della città è vibrante e guarda al futuro. Eventi come la “Giornata dell’Arte e della Cultura Contemporanea” collegano simbolicamente le innovazioni del passato, come il Futurismo, a una nuova stagione artistica. Un nuovo, importante capitolo si sta per aprire con l’inaugurazione di un museo d’arte contemporanea nel duecentesco Palazzo della Ragione. Il museo ospiterà la prestigiosa Sonnabend Collection, portando capolavori di Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Jeff Koons a dialogare con il patrimonio medievale e rinascimentale della città, in un cortocircuito temporale di grande fascino.
(Musica che cresce, mescolando un liuto rinascimentale a un tema moderno e riflessivo)
Tornando all’immagine iniziale della città sull’acqua, la storia di Mantova appare come un susseguirsi di cicli drammatici: il mito che cede il passo alla storia, l’ascesa spettacolare e la caduta rovinosa di una dinastia, il fiorire del genio artistico e il suo soffocamento da parte della guerra. Eppure, gli echi dei Gonzaga, di Mantegna, di Alberti e dei martiri del Risorgimento risuonano ancora nelle sue piazze e nei suoi palazzi. Mantova rimane una città dove il passato non è un ricordo, ma una presenza viva, una testimonianza della forza duratura dell’arte e della resilienza dello spirito umano. È una storia che continua a essere raccontata, non solo nei musei, ma nelle pietre stesse della città.

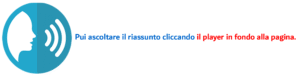























Recensione