La storia di Mantova in breve
Un Viaggio Attraverso i Secoli
Mantova, una delle città più affascinanti della Lombardia, vanta una storia ricca e complessa, profondamente legata alla sua posizione strategica tra i laghi e al dominio di potenti famiglie, in particolare i Gonzaga. La sua evoluzione da insediamento etrusco a gioiello rinascimentale, fino alla sua resilienza contemporanea, ne fa un luogo di eccezionale valore storico e culturale, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
1. Le Origini e il Periodo Romano
Le prime tracce di insediamenti a Mantova risalgono all’età del Bronzo. La città conobbe un primo sviluppo significativo sotto gli Etruschi, che vi fondarono un importante centro abitato intorno al VI secolo a.C., probabilmente legandone il nome al dio etrusco Mantu (dell’oltretomba). Questa fase etrusca fu cruciale per la sua configurazione iniziale e per lo sviluppo di attività commerciali e artigianali.
Successivamente, la regione fu romanizzata. Mantova divenne un municipio romano nel I secolo a.C. e fu un centro agricolo e di scambi. Sebbene non fosse una delle città più grandi dell’Impero, la sua posizione geografica ne garantiva una certa importanza. È durante questo periodo che si colloca la nascita di Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.), il grande poeta latino autore dell’Eneide, originario dell’agro mantovano, un legame che ancora oggi onora la città.
2. Il Medioevo e l’Epoca Comunale
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, Mantova attraversò un periodo di instabilità, segnato dalle invasioni barbariche (Ostrogoti, Longobardi, Franchi). Intorno all’XI secolo, la città divenne un importante centro del Sacro Romano Impero. Matilde di Canossa, potente contessa di Mantova e Toscana, giocò un ruolo fondamentale nel XI e XII secolo, influenzando lo sviluppo urbano e religioso. A lei è tradizionalmente attribuita la costruzione della Rotonda di San Lorenzo, un raro esempio di architettura romanica a pianta centrale, riscoperta e restaurata nel XX secolo dopo secoli di oblio.
Nel XII secolo, come molte città italiane, Mantova divenne un libero Comune. Fu un periodo di vivace sviluppo economico e civile, ma anche di intense lotte intestine tra le fazioni nobiliari e popolari. Queste tensioni portarono gradualmente alla fine dell’autonomia comunale e all’affermazione delle signorie.
3. Il Dominio dei Gonzaga: Splendore e Mecenatismo (1328-1707)
Il periodo più glorioso della storia mantovana è senza dubbio quello della Signoria e poi del Ducato dei Gonzaga, che governarono la città per quasi quattro secoli (dal 1328 al 1707).
- L’Ascesa dei Gonzaga: La famiglia si affermò con Ludovico I Gonzaga, che nel 1328 pose fine al dominio dei Bonacolsi. I Gonzaga, abili politici e condottieri, seppero consolidare il loro potere e trasformare Mantova in una delle corti più raffinate e influenti d’Europa.
- Fortificazioni e Inizi Residenziali: Francesco I Gonzaga commissionò la costruzione del Castello di San Giorgio a Bartolino da Novara (iniziato nel 1395), una fortezza difensiva che divenne il nucleo del futuro Palazzo Ducale. Questo castello, imponente e strategicamente posizionato, segnò l’inizio della magnificenza architettonica gonzaghesca.
- L’Età d’Oro del Rinascimento: Sotto Ludovico II Gonzaga (dal 1459), il Castello di San Giorgio iniziò la sua trasformazione da fortezza a residenza signorile. Ludovico e i suoi successori furono straordinari mecenati delle arti e delle scienze, attirando a Mantova artisti del calibro di Andrea Mantegna, Leon Battista Alberti e Giulio Romano.
- Palazzo Ducale: Il Palazzo Ducale si sviluppò come una “città-palazzo” tentacolare, un complesso di circa 35.000 metri quadrati che comprendeva cortili, giardini e innumerevoli edifici. Al suo interno, Andrea Mantegna realizzò la celebre Camera degli Sposi (1465-1474) nel Castello di San Giorgio, un capolavoro di pittura illusionistica che celebra la famiglia Gonzaga e il suo potere.
- Palazzo Te: Federico II Gonzaga commissionò a Giulio Romano (arrivato a Mantova nel 1524) la costruzione di Palazzo Te (1524-1534), una villa suburbana di svago che rappresenta il manifesto del Manierismo. Con sale come la Sala dei Giganti e la Sala di Amore e Psiche, Giulio Romano creò ambienti immersivi che fusero architettura, pittura e illusionismo in maniera rivoluzionaria. La sua influenza si estese all’urbanistica e ad altre opere, come l’Appartamento di Troia nel Palazzo Ducale e interventi al Duomo.
- Declino del Ducato: Nonostante la grandezza artistica, il Ducato dei Gonzaga subì un progressivo declino a causa di crisi dinastiche, conflitti (come la Guerra di Successione di Mantova e del Monferrato nel XVII secolo) e difficoltà economiche. La dinastia si estinse nel 1707 con la morte di Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, e Mantova passò sotto il dominio asburgico.
4. Il Periodo Post-Gonzaga: Dominazioni Straniere (1707-1866)
Dopo la fine del dominio gonzaghesco, Mantova divenne parte dei territori austriaci. Fu un periodo di riorganizzazione amministrativa e di modernizzazione, ma anche di perdita di autonomia. La città visse periodi di occupazione francese durante le Guerre Napoleoniche, tornando poi sotto il controllo austriaco con la Restaurazione (1815). Durante la dominazione asburgica, il Castello di San Giorgio fu trasformato in un temuto carcere di massima sicurezza.
Mantova, a causa della sua posizione strategica, divenne una delle fortezze del Quadrilatero austriaco, un sistema difensivo cruciale nel nord Italia. Questo la rese un obiettivo primario durante le Guerre d’Indipendenza italiane.
5. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia
Mantova fu un centro cruciale per i moti risorgimentali. La repressione austriaca fu particolarmente dura, culminando nel tragico episodio dei Martiri di Belfiore (1852-1855), un gruppo di patrioti impiccati nel forte di Belfiore per cospirazione. Questo evento simboleggia la feroce lotta per l’indipendenza e l’unità d’Italia.
Mantova fu l’ultima città del Quadrilatero a essere annessa al Regno d’Italia, nel 1866, dopo la Terza Guerra d’Indipendenza. La sua liberazione segnò la fine di secoli di dominio straniero e l’inizio di una nuova era.
6. Mantova Contemporanea
Dopo l’Unità d’Italia, Mantova ha continuato a svilupparsi, preservando il suo inestimabile patrimonio storico-artistico. Nel XX secolo, la città ha affrontato le sfide delle guerre mondiali e i danni causati da eventi naturali, come il terremoto del 2012, che ha colpito anche il Castello di San Giorgio e Palazzo Ducale, richiedendo lunghi e complessi lavori di restauro.
Oggi, Mantova è una città vibrante, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità (insieme a Sabbioneta) dal 2008, in virtù del suo eccezionale valore artistico e architettonico, testimonianza del Rinascimento italiano. La città continua a valorizzare i suoi musei (come il Palazzo Ducale, Palazzo Te, il Teatro Scientifico Bibiena), i suoi monumenti e i suoi eventi culturali (come il Festivaletteratura), attirando visitatori da tutto il mondo e mantenendo viva la sua profonda identità storica e culturale. La sua cucina tradizionale e l’ambiente naturale dei laghi contribuiscono a rendere Mantova una meta turistica e culturale completa.

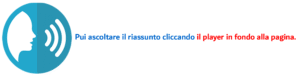























Recensione