Piazza Pallone
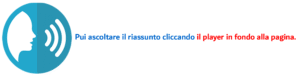
Piazza Pallone a Mantova: Una Storia Approfondita tra Potere, Leggenda e Trasformazione Urbana
1. Introduzione: Il Cuore Nascosto della “Città-Palazzo”
Piazza Pallone, oggi ufficialmente nota come Piazza Lega Lombarda, rappresenta uno spazio urbano di fondamentale importanza e dalle molteplici sfaccettature nel tessuto storico di Mantova. La sua collocazione è unica, essendo una delle “piazze interne” del vasto complesso di Palazzo Ducale, spesso definito la “Città-Palazzo” per la sua imponente scala e la sua natura autosufficiente. Questa posizione privilegiata ne evidenzia immediatamente la profonda integrazione nelle dinamiche di potere e nella vita quotidiana della corte dei Gonzaga.
La piazza ha attraversato un’evoluzione significativa, trasformandosi da un’area di servizio funzionale all’interno del complesso ducale in un giardino pubblico. Questa metamorfosi riflette i più ampi mutamenti urbanistici e politici che hanno interessato Mantova nel corso dei secoli. La piazza si configura come un custode di segreti e racconti, intimamente connessa alla famiglia Gonzaga, che ha retto le sorti di Mantova per quattrocento anni, dal 1328 al 1707. L’analisi della sua storia rivela come questo spazio non sia semplicemente un luogo statico, ma piuttosto un palinsesto storico dinamico, capace di incarnare le mutevoli strutture di potere, le filosofie di pianificazione urbana e le definizioni di spazio pubblico e privato che hanno caratterizzato la città. La piazza, in tal senso, funge da rappresentazione tangibile della traiettoria storica di Mantova, dalla sua funzione di sede ducale fino alla sua configurazione moderna.
2. Origini e Nomenclatura: Un Luogo dai Molti Nomi
Piazza Pallone, sebbene oggi ufficialmente conosciuta come Piazza Lega Lombarda, vanta una storia ricca e complessa, testimoniata dai numerosi nomi che ha assunto nel corso dei secoli. A partire dal Cinquecento, la piazza ha subito diverse modifiche nella sua denominazione, ciascuna delle quali allude a una funzione o a una caratteristica predominante in un dato periodo.
Inizialmente, la piazza era conosciuta come “Plateola cum uno puteo”, una designazione che suggerisce una configurazione più piccola e un ruolo prevalentemente utilitaristico, forse legato alla presenza di un pozzo. Successivamente, fu denominata “piazza alberriggia”. Nel XVII secolo, con la costruzione di Palazzo Canossa, assunse il nome di “piazza del fieno”, indicando un possibile utilizzo come mercato o area di stoccaggio per il foraggio. Altri nomi storici includono “Piazza del Giardino” e “Piazza della Curia”.
Il nome più distintivo e duraturo, “Piazza Pallone”, è profondamente radicato nella sua funzione storica come luogo dedicato al tradizionale “gioco della palla”, in particolare il “pallone col bracciale”. Questa denominazione popolare è rimasta in uso tra i residenti di Mantova nonostante i cambiamenti ufficiali. La progressione dei nomi, da quelli che descrivono caratteristiche fisiche o funzioni economiche a quelli che riflettono usi ricreativi e, infine, commemorazioni politiche, illustra come gli spazi urbani vengano continuamente ridefiniti dalle esigenze sociali e dalle agende politiche dominanti. La persistenza del nome popolare “Piazza Pallone” dimostra la resilienza della memoria culturale e delle pratiche tradizionali di fronte ai tentativi di ri-branding ufficiale.
Il nome ufficiale attuale, “Piazza Lega Lombarda”, fu assegnato nel 1876. Questa ridenominazione probabilmente riflette una commemorazione politica o storica post-unitaria, spostando l’identità della piazza da uno spazio funzionale a uno di più ampio significato storico nazionale o regionale. Questa dinamica tra la governance dall’alto e l’identità culturale dal basso è un elemento chiave nella comprensione dell’identità percepita e reale degli spazi urbani.
Per una chiara comprensione dell’evoluzione della sua nomenclatura, si presenta la seguente tabella:
| Periodo/Data Approssimativa | Nome | Significato/Ragione del Nome | |
| Pre-16° secolo | Plateola cum uno puteo | Piazzetta con un pozzo (utilitaristico) | |
| Successivo | Piazza alberriggia | (Significato incerto, forse legato a alberi o “albergo”) | |
| XVII secolo | Piazza del Fieno | Mercato o area di stoccaggio del fieno | |
| Periodo non specificato | Piazza del Giardino | Spazio verde o ricreativo | |
| Periodo non specificato | Piazza della Curia | (Significato incerto, forse legato a funzioni amministrative o ecclesiastiche) | |
| Popolare e duraturo | Piazza Pallone | Luogo adibito al gioco della palla | |
| 1876 | Piazza Lega Lombarda | Commemorazione politica/storica |
3. La Piazza nel Contesto Ducale: Potere e Architettura Gonzaga
L’identità di Piazza Pallone è indissolubilmente legata alla sua posizione come parte integrante del complesso di Palazzo Ducale, la sede del potere della famiglia Gonzaga. Questo vasto insieme di edifici, cortili e giardini era celebremente descritto come “una città nella città”.
La piazza è situata alle spalle del Palazzo del Capitano e presenta un passaggio che la collega a Piazza Sordello , un’altra piazza chiave nell’assetto gonzaghesco. Storicamente, essa fungeva da area interna al Palazzo Ducale, destinata principalmente ad “attività di servizio”. Questo ruolo evidenzia la sua funzione utilitaristica all’interno della sfera privata della corte prima della sua successiva trasformazione in giardino pubblico.
Le caratteristiche architettoniche della piazza sono una chiara manifestazione del potere e del mecenatismo dei Gonzaga. La piazza è “cinta su tre lati da portici rinascimentali” , realizzati dall’architetto di corte Gian Battista Bertani tra il 1562 e il 1572. L’opera di Bertani, che aveva anche esperienza come pittore e scultore e fu direttore della fabbrica del Duomo , fu una diretta espressione del mecenatismo culturale e del potere di Guglielmo Gonzaga, terzo Duca di Mantova. Questi portici non erano semplici aggiunte estetiche, ma vere e proprie proiezioni dell’autorità ducale, dimostrando come la famiglia Gonzaga utilizzasse il design urbano e la costruzione per affermare la propria magnificenza e il controllo sugli spazi pubblici della città. Sul lato meridionale, la piazza ospita un’esedra che consente l’ingresso al Castello di San Giorgio , sottolineando il suo ruolo di punto di accesso cruciale all’interno del complesso ducale. Tracce di una loggia a due piani, successivamente tamponata, sono visibili su un lato, divenendo parte della sala del Pisanello in Corte Vecchia. Il lato orientale della piazza è dominato dal Palazzo Ducale stesso, articolato nei suoi diversi edifici, tra cui la Magna Domus e il Palazzo del Capitano, quest’ultimo caratterizzato da merli ghibellini e originariamente dimora della famiglia Bonacolsi.
Nel XVIII secolo, con la fine del dominio Gonzaga e l’annessione di Mantova all’Impero Asburgico, la funzione di Palazzo Ducale subì un drastico cambiamento. Perse il suo ruolo primario di sede del potere assoluto e fu riutilizzato per scopi militari (Artiglieria), come sede di magistrature e uffici amministrativi, e come residenza temporanea per rappresentanti imperiali. Un intervento urbanistico significativo avvenne negli anni ’70 del Settecento sotto Ferdinando d’Asburgo-Lorena: l’ingresso principale al palazzo, precedentemente situato “in un angolo del cortile detto del Pallone”, fu spostato sulla facciata verso Piazza del Duomo. Questo spostamento strategico alterò la preminenza della piazza come punto d’ingresso e riflette una ri-orientazione della facciata pubblica del palazzo. Questa modifica fisica, dal controllo privato e dinastico dello spazio a una funzione più pubblica e amministrativa, è un chiaro indicatore di come i cambiamenti nel potere politico abbiano influenzato direttamente la gerarchia funzionale e simbolica degli spazi urbani all’interno del complesso palatino. La piazza, dunque, non era solo un cortile statico, ma un punto dinamico di passaggio e connessione, che facilitava il movimento e l’interazione all’interno del complesso tessuto urbano di Mantova, riflettendo la natura gerarchica del potere ducale.
4. Il Gioco del Pallone: Tradizione e Vita Quotidiana
L’aspetto più distintivo e duraturo della storia di Piazza Pallone, nonché l’origine del suo nome popolare, è la sua lunga associazione con il tradizionale gioco italiano conosciuto come “pallone col bracciale”.
Il “pallone col bracciale” era considerato il “gioco classico degli italiani”. Veniva praticato da squadre di tre atleti (battitore, spalla e terzino) che utilizzavano un “bracciale”, una sorta di guanto in legno con punte, per colpire una palla. L’obiettivo era colpire la palla al volo, dopo il primo rimbalzo, o “di scozzo” (dopo che aveva urtato contro il muro), e ricacciarla nel campo avversario. I punti venivano segnati se la palla non veniva raccolta dall’avversario (detto “volata”), se andava fuori dai lati maggiori del campo, o se non superava la propria metà campo. Il gioco era praticato in sferisteri dedicati o, come a Mantova, in una piazza adattata allo scopo. Il campo era lungo tra i 90 e i 100 metri e largo tra i 16 e i 20 metri, con un alto muro di appoggio. La palla stessa era inizialmente fatta di stracci legati e arrotolati, poi di elastici ricavati da camere d’aria di biciclette, e storicamente, di pelle cucita attorno a un’intelaiatura di filo rigido, riempita di capelli femminili o pelo di gatto. Queste palle avevano un diametro di 4 o 5 centimetri e pesavano tra i 30 e i 40 grammi, simili alle attuali palline da tennis. La terminologia del gioco includeva “quindici” per un punto realizzato e esclamazioni come “aiuto!” o “a te!”.
L’uso della piazza per questo gioco fu così significativo da diventarne il nome comune tra i residenti di Mantova. Il gioco era popolare e diffuso, con menzioni di analoghe “via pallone” o “via gioco del pallone” in altre città come Verona e Ferrara. Sebbene le origini esatte del gioco siano difficili da datare con certezza, il periodo rinascimentale vide una rinascita delle manifestazioni “ludico sportive”, in particolare dei giochi con la palla. L’imperatore Carlo V stesso partecipò a un torneo di “pallacorda” durante l’inaugurazione di Palazzo Te nel 1530.
Il fatto che il nome popolare più duraturo della piazza, “Piazza Pallone”, derivi direttamente dal suo utilizzo per il gioco del “pallone col bracciale” indica che, al di là delle sue funzioni ducali formali, lo spazio fungeva da vivace centro di ricreazione popolare. Ciò suggerisce che gli spazi urbani, anche quelli all’interno di complessi di corte potenti, non erano esclusivamente destinati ad attività elitarie, ma accoglievano e venivano plasmati anche dalle pratiche di svago e sociali della gente comune. Le descrizioni dettagliate del gioco evidenziano una ricca tradizione culturale che ha conferito alla piazza un’identità distinta, rendendola un luogo di aggregazione e intrattenimento per la comunità, colmando così il divario tra il potere formale del Palazzo Ducale e la vita quotidiana dei cittadini mantovani. Nonostante il declino della popolarità del gioco in tempi più recenti , la sua presenza storica in Piazza Pallone è così forte da rimanere il nome comune anche nell’era moderna. Questo dimostra come le pratiche culturali, anche quando non più attivamente eseguite in un luogo specifico, possano lasciare un segno indelebile nella coscienza collettiva e nella nomenclatura di un luogo. L’idea che la palla “rimbalzi ancora” nella memoria sottolinea le profonde radici storiche e culturali del gioco a Mantova, suggerendo che la piazza funge da monumento vivente a questa tradizione passata, promuovendo un senso di continuità con il passato.
5. Agnese Visconti: La Tragedia e la Leggenda
Piazza Pallone è indelebilmente segnata da una delle leggende più tragiche e durature della corte dei Gonzaga: la storia di Agnese Visconti. Il suo destino è un commovente monito alle dure realtà del potere, del matrimonio e della giustizia nei periodi medievale e rinascimentale.
Agnese Visconti (1363-1391 o 1397) era figlia di Bernabò Visconti, Signore di Milano, e di Beatrice Regina della Scala. Sposò Francesco I Gonzaga, Signore di Mantova, in giovane età (14 o 17 anni lei, circa 15 lui). Questo matrimonio era un’alleanza politica, volta a rafforzare i legami tra le famiglie Visconti e Gonzaga. Da Agnese ci si aspettava un erede maschio per Mantova, ma ella diede alla luce solo una figlia, Alda.
Agnese fu accusata di adulterio con il cavaliere Antonio da Scandiano o Vincenzo da Scandiano. È importante notare che vi è una discrepanza nel nome di battesimo dell’amante tra le fonti. La data della sua esecuzione varia anch’essa: alcune fonti indicano il 7 febbraio 1391 , mentre altre riportano il 7 febbraio 1397. Nonostante la maggioranza delle fonti indichi il 1391, la variazione temporale merita attenzione. Agnese fu decapitata, mentre il suo presunto amante fu strangolato o impiccato. La ragione ufficiale della condanna fu l’adulterio, che all’epoca comportava pene severe. Tuttavia, alcune teorie suggeriscono che macchinazioni politiche legate ai mutamenti delle alleanze di Francesco I Gonzaga abbiano giocato un ruolo determinante nella sua fine. Una testimonianza oculare durante il processo descrisse incontri intimi in alcune stanze del Palazzo Ducale, tra cui una “camera Lanzaloti” e una “camera dei Cimieri” vicino alla “camera degli Imperatori”.
Sia Agnese che il suo presunto amante furono sepolti insieme in quella che oggi è Piazza Pallone, il cortile del Palazzo Ducale. Una lapide commemorativa è ancora presente nella piazza, a ricordo della loro tragica fine, fungendo da tangibile testimonianza dell’evento. La storia di Agnese Visconti, culminata nella sua esecuzione e sepoltura in Piazza Pallone, trasforma la piazza da un semplice cortile in un luogo di profondo dramma storico. La sua morte, sia essa dovuta all’adulterio o a intrighi politici, evidenzia il potere assoluto esercitato da famiglie regnanti come i Gonzaga e le severe conseguenze per coloro che trasgredivano la loro autorità o i loro interessi politici. La presenza della lapide commemorativa assicura che questo evento rimanga un elemento permanente nella narrativa della piazza, dimostrando come gli spazi pubblici possano fungere da monumenti duraturi sia al potere che alla tragedia. Questo suggerisce che la piazza non era solo uno spazio funzionale, ma un’arena simbolica in cui i Gonzaga affermavano il loro controllo, anche attraverso atti di estrema violenza.
Secondo la leggenda locale, il grido disperato di Agnese Visconti può ancora essere udito di notte in Piazza Pallone, con il suo fantasma che infesta Palazzo Ducale. Questa credenza aggiunge uno strato di folklore e memoria culturale all’evento storico. La coesistenza di registrazioni storiche dell’esecuzione di Agnese e della leggenda popolare del suo fantasma illustra come i fatti storici possano intrecciarsi con il folklore per creare una narrazione più ricca ed emotivamente risonante. La discrepanza nell’anno dell’esecuzione, come si evince dalle diverse fonti, esemplifica ulteriormente come la memoria storica possa essere fluida e plasmata da resoconti o interpretazioni diverse nel tempo. Ciò implica che la piazza funziona come un luogo dove il passato non è solo ricordato, ma attivamente reinterpretato e ri-narrato attraverso sia la ricerca accademica che l’immaginazione popolare, contribuendo alla sua unica identità culturale.
6. Trasformazioni Post-Gonzaga: Dal Settecento all’Epoca Moderna
Con la fine della dinastia Gonzaga nel 1707, Mantova, e di conseguenza Piazza Pallone, entrarono in una nuova fase di trasformazione sotto il dominio austriaco. Questo periodo segnò un significativo passaggio da sede ducale a centro amministrativo imperiale, influenzando la funzione e l’aspetto della piazza.
Nel XVIII secolo, sotto il dominio austriaco, il Palazzo Ducale, avendo perso il suo ruolo di sede primaria del potere, fu riadattato per vari usi, tra cui artiglieria, magistrature e uffici amministrativi. Un importante intervento urbanistico si verificò negli anni ’70 del Settecento sotto Ferdinando d’Asburgo-Lorena, che avviò una vasta campagna di ristrutturazione. In particolare, l’ingresso principale del Palazzo Ducale, precedentemente situato in un angolo di Piazza Pallone, fu spostato sulla facciata prospiciente Piazza del Duomo. Questo cambiamento alterò significativamente il flusso di persone e l’importanza simbolica di Piazza Pallone come punto di accesso primario. La ristrutturazione comportò anche la regolarizzazione delle facciate e la creazione di nuovi appartamenti all’interno del palazzo per amministratori e sovrani di passaggio. Il passaggio dal governo Gonzaga all’amministrazione austriaca portò direttamente alla riorganizzazione funzionale del Palazzo Ducale e allo spostamento del suo ingresso principale lontano da Piazza Pallone. Questa alterazione fisica simboleggia un più ampio cambiamento nella governance urbana, da un controllo privato e dinastico dello spazio a una funzione più pubblica e amministrativa.
Dalla sua precedente funzione di area di servizio interna al Palazzo Ducale, Piazza Pallone si è evoluta in un “ampio spazio sistemato a giardino pubblico”. Questa trasformazione riflette una tendenza più generale nella pianificazione urbana verso la creazione di spazi verdi per il godimento pubblico. Tra le aiuole sono distribuiti busti di “illustri locali”. Ad esempio, un monumento al Principe Maurizio Ferrante Gonzaga (1861-1938), un generale decorato, si erge nella piazza. Questo evidenzia il ruolo della piazza nella commemorazione civica.
Tra le caratteristiche moderne, è presente un'”antica edicola liberty di giornali”, risalente al 1882 e restaurata a cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Questo dettaglio aggiunge un tocco di fascino storico moderno e indica gli sforzi in corso per la conservazione. La piazza continua a essere uno spazio pubblico vivace, sebbene gli elenchi attuali di eventi non la menzionino specificamente come sede. La presenza dell’antica edicola Liberty del 1882, accanto ai portici rinascimentali e ai busti commemorativi dei principi Gonzaga, crea un ricco arazzo di strati storici all’interno della piazza. Questi elementi, che abbracciano secoli, non sono semplici caratteristiche isolate, ma contribuiscono a una narrazione continua dell’evoluzione della piazza. Il restauro dell’edicola da parte del FAI sottolinea un apprezzamento contemporaneo e la volontà di preservare questi strati storici. Ciò suggerisce che Piazza Pallone funziona come un museo a cielo aperto, dove diverse epoche della storia mantovana sono visibilmente iscritte nel suo tessuto urbano, invitando i visitatori a ripercorrere il suo passato multiforme attraverso i suoi dettagli architettonici e commemorativi.
7. Conclusione: Un Palinsesto Storico nel Cuore di Mantova
Piazza Pallone, o Piazza Lega Lombarda, si erge come una straordinaria testimonianza della ricca e complessa storia di Mantova. Dalle sue origini come cortile funzionale all’interno della formidabile “Città-Palazzo” dei Gonzaga, si è continuamente evoluta, assorbendo e riflettendo i profondi cambiamenti che hanno plasmato la città.
La sua mutevole nomenclatura – da “Plateola cum uno puteo” a “Piazza del Fieno” e infine “Piazza Lega Lombarda”, pur mantenendo popolarmente “Piazza Pallone” – sottolinea la dinamica interazione tra l’identità amministrativa formale e una memoria culturale profondamente radicata. Il nome popolare duraturo è un diretto omaggio alla vibrante tradizione del “pallone col bracciale”, un gioco che un tempo animava questo spazio e gli conferiva il suo carattere unico.
Dal punto di vista architettonico, la piazza è un documento vivente del potere e del mecenatismo dei Gonzaga, in particolare attraverso i portici rinascimentali di Gian Battista Bertani. La sua posizione strategica e lo spostamento dell’ingresso principale del Palazzo Ducale rivelano il suo ruolo adattabile all’interno del tessuto urbano, riflettendo i cambiamenti nella governance dal dominio ducale a quello austriaco. La piazza funge da crocevia di narrazioni storiche intersecanti, dove potere, cultura e dramma umano si fondono.
Forse il suo aspetto più avvincente è l’associazione con la tragica leggenda di Agnese Visconti, la cui esecuzione e sepoltura nella piazza fungono da commovente promemoria dei drammi umani intrecciati con il potere dinastico. La lapide commemorativa e la persistente storia del fantasma assicurano che questo elemento umano rimanga centrale nella sua narrazione. Non si tratta semplicemente di un luogo definito da un singolo evento o funzione storica, ma piuttosto dall’interazione complessa di tutti questi elementi.
Oggi, come ampio giardino pubblico adornato con monumenti e una storica edicola, Piazza Pallone continua a servire come un vitale luogo di aggregazione, collegando il suo illustre passato con la vita urbana contemporanea. Questa persistenza della memoria e dell’identità, anche quando le funzioni o i nomi ufficiali cambiano, implica che i luoghi sviluppano un significato culturale profondo che trascende i meri attributi fisici o i decreti amministrativi. È veramente un palinsesto storico, dove ogni strato racconta una storia di potere, tradizione, tragedia e continua trasformazione, rendendola un punto focale indispensabile per comprendere il cuore di Mantova e un elemento integrante della sua identità collettiva.
Le Origini del Nome e l’Evoluzione Storica
Il nome più comune e tradizionale, “Piazza Pallone”, deriva dall’antica consuetudine di utilizzare questo spazio per il gioco della palla. Questo sport era già molto diffuso e popolare, tanto da lasciare il suo nome a piazze e vie in altre città italiane come Verona e Ferrara. Il toponimo attuale, Piazza Lega Lombarda, le fu assegnato solo nel 1876, ma in passato fu conosciuta anche come Piazza del Giardino e Piazza della Curia.
In origine, l’area era un vasto spazio interno al Palazzo Ducale, destinato ad attività di servizio. Si apriva alle spalle del Palazzo del Capitano e vi era un passaggio che la collegava a Piazza Sordello.
Il Periodo Medievale e l’Avvento dei Gonzaga
Sebbene l’area intorno a Piazza Sordello fosse il cuore della Mantova medievale, anche Piazza Pallone ha le sue radici in quel periodo. Era un luogo ideale per gli esercizi di addestramento cavalleresco, come dimostrano le raffigurazioni di giostre e tornei nell’arte del Pisanello, che si svolgevano anche in questa piazza.
La svolta decisiva per Mantova e per questa piazza avvenne nel 1328, quando i Gonzaga presero il potere, spodestando i Bonacolsi. Per 400 anni, fino al 1707, i Gonzaga ressero le sorti della città, trasformando il Palazzo Ducale (di cui Piazza Pallone fa parte integrante) in una “città nella città”, un complesso imponente di edifici, cortili e giardini.
L’Epoca Gonzaghesca: Splendore e Tragedie
Durante l’epoca gonzaghesca, Piazza Pallone assunse un ruolo sempre più centrale. Circondata su tre lati da portici rinascimentali, realizzati in parte dall’architetto di corte Gian Battista Bertani tra il 1562 e il 1572, divenne un simbolo del mecenatismo culturale e del potere di duchi come Guglielmo Gonzaga.
Tuttavia, la piazza fu anche teatro di eventi tragici. Una delle storie più toccanti legate a Piazza Pallone è quella di Agnese Visconti. Sesta di diciassette figli, Agnese sposò Francesco I Gonzaga a soli 14 anni. La coppia ebbe solo una figlia, Alda, e la mancata nascita di un erede maschio, unita a complesse dinamiche politiche legate all’ascesa di Gian Galeazzo Visconti a Milano, portò a una drammatica accusa di adulterio. Agnese fu condannata a morte e decapitata il 7 febbraio 1391, mentre il presunto amante, Antonio da Scandiano, venne impiccato. Si racconta che le loro sepolture si trovino proprio nell’attuale Piazza Pallone, dove campeggia una targa in memoria della sfortunata duchessa, e che di notte si possa ancora sentire il suo grido disperato.
Il Settecento e le Trasformazioni Successive
Con la fine della dinastia gonzaghesca e l’arrivo degli Asburgo nel Settecento, Palazzo Ducale subì diverse trasformazioni. L’ingresso principale al palazzo, che in precedenza era posto in un angolo del cortile del Pallone, fu spostato sulla facciata verso la piazza del Duomo. Nonostante le esigenze militari che talvolta portarono all’utilizzo del palazzo per alloggiare truppe, il suo riconosciuto valore artistico ne impedì una trasformazione stabile in caserma.
Nel corso dei secoli, la piazza ha continuato a evolversi. Oggi, Piazza Lega Lombarda è un ampio spazio sistemato a giardino pubblico, circondato da profumati tigli, un luogo di riposo per i cittadini. Al suo interno sono distribuiti i busti di illustri personaggi locali, e si racconta che un tempo fosse occupata da un giardino e utilizzata per tornei cavallereschi.
In sintesi, Piazza Pallone/Piazza Lega Lombarda è un luogo che racchiude in sé secoli di storia mantovana, dal medioevo al rinascimento gonzaghesco, fino ai giorni nostri, testimoniando evoluzioni urbanistiche, eventi drammatici e il perpetuarsi di leggende che ancora oggi affascinano e commuovono.
























Recensione