Casa del Mantegna
Andrea Mantegna e la sua Casa a Mantova: un Universo di Arte e Intelletto nel Cuore del Rinascimento
Andrea Mantegna (c. 1431-1506), uno dei più fulgidi e innovativi maestri del Rinascimento italiano, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte, non solo attraverso le sue potenti tele e i suoi affreschi rivoluzionari, ma anche con un monumento unico alla sua stessa visione del mondo: la Casa del Mantegna a Mantova. Questa dimora, straordinario esempio di architettura rinascimentale, non fu solo l’abitazione e lo studio di un artista, ma l’incarnazione fisica dei suoi ideali estetici, della sua passione per l’antichità classica e del suo elevato status sociale raggiunto alla corte dei Gonzaga.
Andrea Mantegna: Dalle Origini Umili alla Gloria a Corte
Nato a Isola di Carturo, vicino Padova, da una famiglia di umili origini, il giovane Andrea mostrò un talento precoce per il disegno. La sua formazione artistica avvenne nella fiorente bottega padovana di Francesco Squarcione, un personaggio singolare, più un imprenditore e un appassionato collezionista di antichità che un grande pittore. Fu in questo ambiente, saturo di frammenti di sculture romane, calchi e disegni, che Mantegna sviluppò il suo amore viscerale per il mondo classico. La sua pittura si distinse presto per il tratto incisivo, quasi scultoreo, la padronanza magistrale della prospettiva e una profonda intensità drammatica. Opere giovanili come gli affreschi della Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani a Padova (in gran parte distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale) rivelarono già la sua grandezza.
La svolta nella sua carriera avvenne nel 1460, quando Ludovico III Gonzaga, marchese di Mantova, lo nominò pittore di corte. Mantova, sotto i Gonzaga, era un vivace centro culturale e politico. La corte era frequentata da umanisti, letterati e architetti di fama, tra cui il celebre Leon Battista Alberti. In questo ambiente stimolante, il talento di Mantegna trovò terreno fertile per sbocciare in tutta la sua magnificenza. Per i Gonzaga, l’artista non era un semplice artigiano, ma un intellettuale, un consigliere e un amico, partecipe della vita e della propaganda della signoria.
Il suo capolavoro indiscusso di questo periodo è la “Camera degli Sposi” (o Camera Picta), affrescata nel Castello di San Giorgio tra il 1465 e il 1474. Quest’opera rivoluzionò la pittura di interni, sfondando illusionisticamente le pareti e il soffitto con scene di vita di corte e un celebre oculo dal quale si affacciano putti e damigelle. Altre opere fondamentali del suo periodo mantovano includono i “Trionfi di Cesare”, un’imponente serie di tele che ricreano la magnificenza di una processione trionfale romana, e il “Cristo Morto”, una delle rappresentazioni più potenti e drammatiche della pittura di tutti i tempi, con il suo audace e straziante scorcio prospettico.
La Casa del Mantegna: Un’Architettura dell’Anima
Fu proprio come segno di stima e riconoscimento per il suo genio che, nel 1476, Ludovico Gonzaga donò a Mantegna il terreno su cui l’artista avrebbe edificato la propria casa, un progetto ambizioso che lo impegnò per quasi vent’anni. Situata in una posizione strategica, non lontana dal centro del potere gonzaghesco e dalla chiesa di San Sebastiano progettata da Alberti, la Casa del Mantegna è un manifesto dell’ideale umanistico dell’artista.
Un’Architettura Geometrica e Simbolica:
La caratteristica più straordinaria e celebre della casa è la sua pianta: un perfetto quadrato al cui centro si apre un cortile circolare. Questa scelta non è casuale, ma risponde a una precisa volontà simbolica e geometrica, che riflette i principi dell’architettura classica e le teorie neoplatoniche in voga all’epoca. Il cerchio inscritto nel quadrato è una rappresentazione della perfezione divina (il cerchio) che si manifesta nel mondo terreno (il quadrato), un simbolo dell’armonia universale che l’uomo del Rinascimento si sforzava di comprendere e replicare.
Questa concezione geometrica richiama da vicino le teorie di Leon Battista Alberti, presente a Mantova in quegli anni. Sebbene non vi siano prove documentali che attestino un coinvolgimento diretto di Alberti nel progetto, è innegabile che la Casa del Mantegna sia intrisa del suo spirito razionalista e del suo richiamo ai modelli classici. Alcuni studiosi ipotizzano che Mantegna stesso, profondo conoscitore dell’antichità e delle leggi della prospettiva, possa essere stato l’architetto della sua dimora, traducendo in pietra e mattoni i principi che governavano la sua pittura.
La Struttura e gli Spazi:
L’edificio si sviluppa su due piani, con un esterno sobrio e quasi austero, in mattoni a vista, che contrasta con la sorprendente apertura del cortile interno. Le stanze si affacciano su questo spazio centrale, che funge da fulcro luminoso e distributivo dell’intera abitazione. Si ritiene che il piano terra fosse destinato alla bottega e agli ambienti di rappresentanza, mentre il piano superiore ospitasse gli appartamenti privati dell’artista e della sua famiglia.
Un’epigrafe, oggi perduta ma tramandata dalle fonti, recitava: “Tu che vedi che io sono stato innalzato per volere di Andrea Mantegna, sappi che sono felice e illustre per il suo genio”. Questa frase testimonia l’orgoglio dell’artista per la sua creazione, un vero e proprio autoritratto in forma di edificio, un monumento alla sua intelligenza e al suo status.
Le Vicende della Casa:
Nonostante l’impegno profuso nella sua costruzione, Mantegna abitò nella sua casa solo per un breve periodo, dal 1496 circa al 1502. Oppresso da difficoltà economiche negli ultimi anni della sua vita, fu costretto a vendere l’amata dimora al marchese Francesco II Gonzaga, figlio di Ludovico. La casa rimase di proprietà dei Gonzaga e, nei secoli successivi, subì vari passaggi di proprietà e destinazioni d’uso.
Eredità e Significato
Andrea Mantegna morì a Mantova il 13 settembre 1506 e fu sepolto in una cappella da lui stesso decorata nella Basilica di Sant’Andrea, un altro capolavoro albertiano. La sua eredità artistica è immensa: la sua riscoperta archeologica dell’antico, il suo rigore prospettico e la sua capacità di infondere un’intensa carica emotiva nelle sue figure hanno influenzato generazioni di artisti, da Albrecht Dürer a Correggio, fino ai pittori barocchi.
La Casa del Mantegna, oggi sede di mostre ed eventi culturali, rimane a testimoniare la grandezza del suo ideatore. È più di un semplice edificio; è un’opera d’arte totale, un microcosmo che racchiude gli ideali di un’epoca e la visione di un artista che, come pochi altri, ha saputo fondere in un’unica, potente sintesi, l’eredità del mondo classico e lo spirito innovatore del Rinascimento. Visitarla significa entrare nell’universo mentale di Andrea Mantegna, un mondo fatto di rigore matematico, passione per la storia e una profonda, umanissima celebrazione dell’uomo e del suo ingegno.

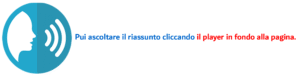























Recensione